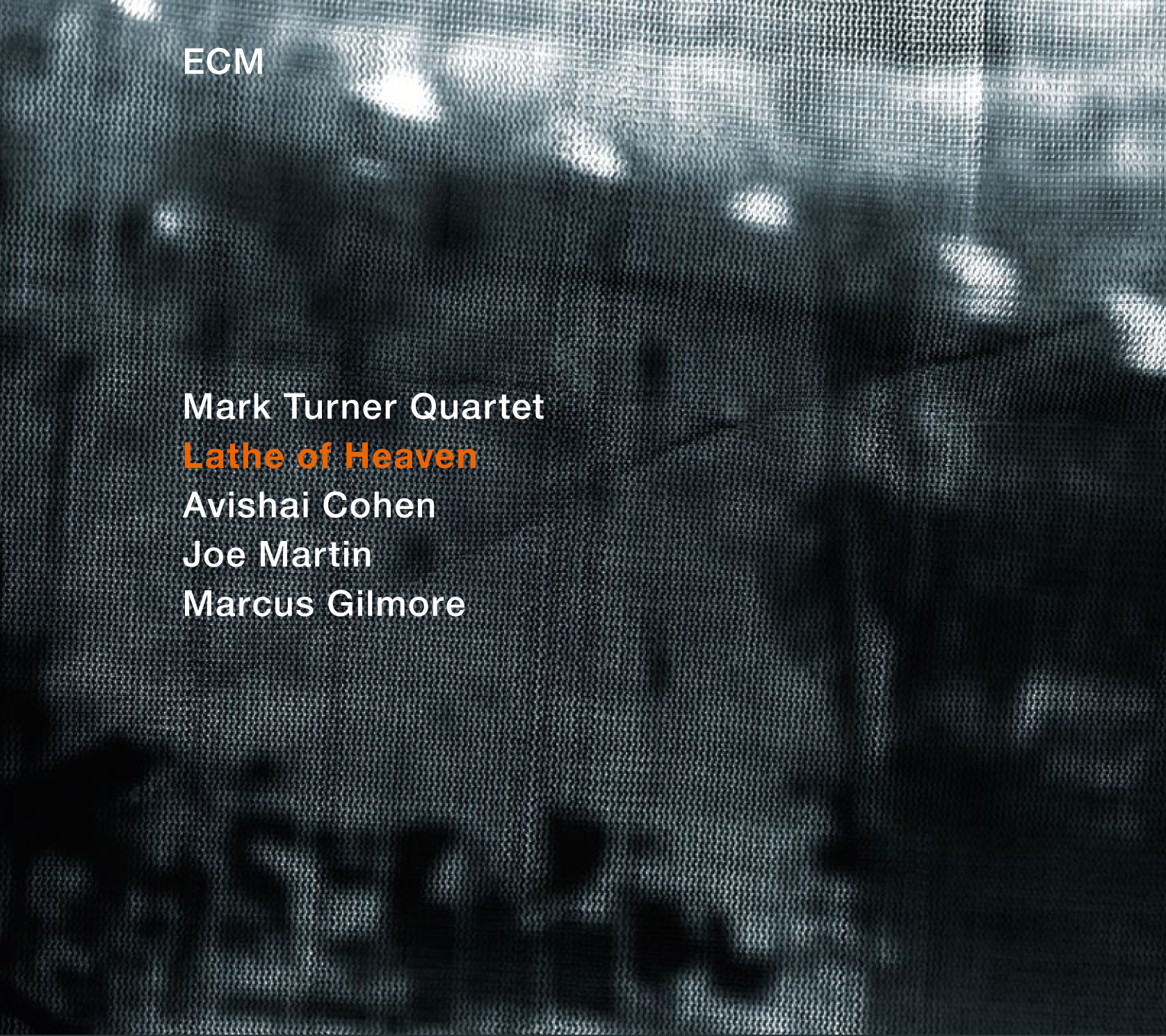L’etichetta di Manfred Eicher rappresenta da oltre quarant’anni, lo sanno tutti, non solo una sigla discografica ma quasi una filosofia della musica. Il suono Ecm, appunto. “Particolare, evocativo di grandi spazi incontaminati”, come ha scritto recentemente Giordano Montecchi. E che si e’ reso protagonista, dall’alba degli anni Settanta, di una svolta epocale rispetto ad un panorama fino ad allora dominato da etichette “storiche” come la Blue Note o la Verve. Che, ancora oggi (nonostante le alterne fortune non abbiano risparmiato nemmeno questi marchi tanto rappresentativi), custodiscono invece il retaggio di una tradizione intrisa di blues, di hard bop, di assoli e arrangiamenti celebri che hanno fatto la storia “profonda” del jazz.
Se questa dicotomia e’ vera, e in effetti (fermo restando poi, in realtà, questo va da se’, la ricchezza multiforme e spesso “controcorrente” dei gloriosi cataloghi di tutte e tre le etichette citate) lo e’ al punto tale da ingenerare infinite – naturalmente fertili – discussioni quando non veri e propri schieramenti fra gli appassionati di jazz , allora questo album e’ senza alcun dubbio di quelli significativi nella produzione di questi anni.
Esce infatti per l’etichetta di Monaco, e ci sta a pennello per il carattere sobrio, appartato, “bioetico”, di questa disarmante musica. Ma poteva essere stato prodotto anche sotto altro “marchio”, quelli citati o quelli che alla “tradizione” Blue Note o Verve si richiamano, come ad esempio la Criss Cross – e infatti il debutto di Mark Turner da solista avvenne proprio, diciannove anni fa, esattamente su Criss Cross (ci riferiamo a “Yam Yam”, in cui al pianoforte sedeva un certo Brad Mehldau) — e ci sarebbe stato benissimo lo stesso: per le venature blues che lo percorrono da cima a fondo ma in particolare nel grande “Sonnet for Stevie”, omaggio a Stevie Wonder e alla sua “Blame It on the sun” e quindi a tutto un mondo che dal soul arriva all’hip hop attraverso il rhythm and blues; per i richiami a grandi esperienze del free afroamericano come quelle del quartetto di Charles Brackeen (che aveva l’identica – rara, o comunque poco usuale – formazione di questo Mark Turner Quartet, che differisce anche dallo storico quartetto senza pianoforte di Ornette in quanto Turner e’ un tenorista) o del trio di Frank Right, e quindi anche di etichette come la Esp Disk.
Questo ad affermare che “Lathe of heaven” e’ oltre le categorie precostituite. Sfida le definizioni gia’ risapute. Con la sua spaziosa, spugnosa liberta’ armonica, e’ uno di quegli album capaci di farci misurare la distanza, l’evoluzione, la sintesi, di cui e’ capace il discorso jazzistico nel secondo decennio del ventunesimo secolo in rapporto ad esperienze anche contrapposte, se non apparse addirittura inconciliabili degli ultimi decenni. E quindi passibili poi di stagnazioni, sia creative che dichiarative. In questa musica al contrario tutto e’ in movimento, e mostra singolari, inattese, elettrizzanti aperture. Gia’ recensitissimo anche se appena uscito, qualcuno di quest’album ha scritto che esso, profondamente meditativo, nel tempo stesso in cui ci riporta alla mente pietre di paragone disparate come il jazz anni Settanta di Kenny Wheeler, o addirittura quello West Coast e “cool” del quartetto “pianoless” di Chet Baker e Gerry Mulligan, rivela un suono che è al tempo stesso familiare e del tutto nuovo.
Ecco: un suono familiare e, nel contempo, del tutto nuovo. E’ probabilmente in ultima analisi questa la cifra espressiva della raccolta di cui stiamo ragionando. Un jazz di sintesi. E che non c’entra niente, naturalmente, con la “contaminazione” di generi, in piu’ di un caso incontrollata e superficiale, a volte senz’anima, di tanta musica che ci suona intorno.
Certo, dobbiamo un tale “miracolo” a un autentico stratega del sax tenore quale Mark Turner e’, che prende come modello nientemeno che Warne Marsh, il piu’ geniale, sottovalutato, intellettuale e contrappuntistico protagonista del jazz di matrice bianca, “attraversandolo” con l’empito di un Joe Henderson o del Coltrane piu’ “Prestige” e piu’ “The avant-garde” (l’lp con Don Cherry, Charlie Haden e alla batteria Percy Heath o Ed Blackwell).
Al suo mondo compositivo, di respiro, sottile, lacerato, avvertito. Ad un protagonista del jazz di oggi capace di farci aspettare quasi tredici anni ( da “Dharma days” del 2001 su Warner Bros!) per ritrovarlo completamente leader di un suo album, e pero’ poi capace in tutti questi anni di assurgere a stella di prima grandezza nel firmamento jazzistico internazionale personalizzando, con firma d’autore, tanto le sue partecipazioni (Robert Glasper, Billy Hart, Enrico Rava per non citarne che tre fra le tante), che le sue “cooperative sonore” ( quasi impareggiabile quella del Fly Trio con Larry Granadier e Jeff Ballard).
Infine, dobbiamo tale exploit a questo quartetto nuovo di zecca, sfolgorante di talenti: in primis quello di Avishai Cohen, la cui tromba trova intrecci sonori, contrappuntistici e solistici col tenore del leader degni di analisi. Poi quello del contrabbasso di Joe Martin attraverso le cui corde scorre tutto il flusso armonico dell’album. E infine della batteria di Marcus Gilmore, che offre una pulsazione potente e sapiente, inesausta, spasmodicamente attenta. Un allievo di Roy Haynes ed e’ tutto dire.
Musicisti:
Mark Turner, tenor saxophone
Avishai Cohen, trumpet
Joe Martin,double bass
Marcus Gilmore, drums
Brani:
01. Lathe of Heaven
02. Year of the Rabbit
03. Ethan’s Line
04. The Edenist
05. Sonnet for Stevie
06. Brother Sister 2
Link:
Mark Turner
ECM Records